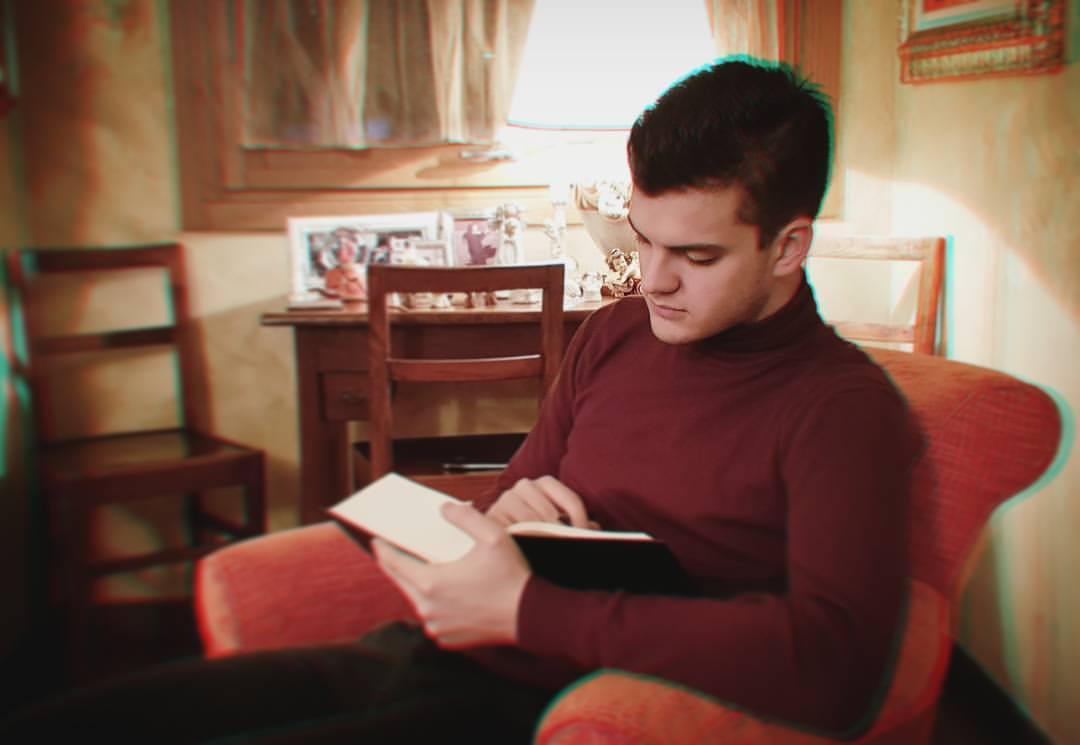Marcello Veneziani è un giornalista e scrittore raffinato, da sempre vigile ai temi della Tradizione e dell’identità. Con l’impegno speso attraverso articoli, libri e convegni non ha mai smesso di cogliere le dissonanze che pervadono il nostro tempo. Lo abbiamo incontrato alla conferenza “Cinquant’anni dal ’68” a Padova – argomento su cui ha dedicato “Rovesciare il ’68”, uno dei suoi numerosi libri – per rivolgergli alcune domande sulla situazione politica attuale e sullo scenario culturale del nostro Paese in vista delle elezioni del quattro marzo. Teniamo a ringraziarlo per la cortesia e disponibilità.
I media non fanno che parlare di fascismo e antifascismo. Altri percepiscono un clima da “strategia della tensione” come negli anni ’70: per lei è calzante questa analogia? Ma soprattutto, ha ancora senso parlare di fascismo e antifascismo?
Non ha più senso dividere il mondo tra fascismo e antifascismo, non è eterno il fascismo e tantomeno può essere eterno il suo anti. Ritengo che l’antifascismo meriti rispetto fin quando il fascismo è imperante. È un atto di coraggio, di non conformismo, di libertà e dignità ribellarsi a un regime. Ma l’antifascismo a babbomorto, l’antifascismo in assenza di fascismo, con l’antifascismo al potere, è insensato e un po’ vile. O peggio, serve ad altri scopi, e dunque diventa – come Samuel Johnson disse del patriottismo – “l’ultimo rifugio dei farabutti”. Né ha molto senso gridare alla rinascita del fascismo che è agitata periodicamente da settant’anni. In realtà un neofascismo è sempre esistito, dentro e fuori del parlamento, ma è sempre stato una nicchia marginale ai bordi della politica. Anzi oggi mi sembra ancora più irrilevante e per giunta percorso da un desiderio di parlamentarizzazione, per entrare nel gioco politico e non certo per tentare un movimento eversivo.
Cosa pensa di un giovane che oggi si definisce fascista?
Cerco di capire meglio in che senso si definisce fascista. Se lo fa perché si è appassionato di un’immagine, un’icona, un poster, una fiction, o deve il suo fascismo a uno slogan, magari allo stadio, non lo prendo sul serio. Se invece lo fa perché non si accontenta di come gli hanno raccontato la storia, per ribellarsi al conformismo, per rimarcare la sua rivolta dal nostro tempo, e vuol saperne di più, posso capire e anzi non nascondo che mi può fare pure simpatia. In ogni caso gli direi di coltivare il suo diverso giudizio storico sul fascismo leggendo, pensando, ascoltando, ma di non spenderlo sul piano politico, perché il fascismo è un’esperienza del passato, irrimediabilmente trascorsa e irripetibile. E lo esorterei a vedere tutto del fascismo e non solo una parte, a capire la tragedia e a coglierne i trionfi, a vedere gli errori e insieme il consenso, le grandi opere realizzate e gli odiosi soprusi fatti in suo nome. Storicizzare il fascismo, anziché patirlo fanaticamente, come una passione presente. Come fanno gli antifascisti di riporto.
L’antifascismo sembra essere ancora un valido collante per la sinistra, Lei cosa ne pensa?
La sinistra, ancor più della destra, riesce a unirsi solo se ha un nemico da odiare: ieri il berlusconismo, oggi (e sempre) l’antifascismo. Non distingendo chi nell’antifascismo cercava la libertà e la democrazia e chi invece sognava la dittatura del proletariato e la rivoluzione comunista. Oggi quel collante funziona ancora per portare in piazza tutta la sinistra, da Renzi ai centri sociali, passando per l’Anpi, Gentiloni, le due o ventidue sinistre politiche: è un collante che unisce la sinistra ma la divide dal paese, la separa dagli italiani e dalla realtà presente. Li riduce a una setta a cui corrisponde un’area d’opinione fanatica e minoritaria.
Il pensiero di molti è che oggi la destra faccia circolare poche idee e che cavalchi principalmente l’onda di un disagio diffuso. Questo atteggiamento “furbesco” è proprio della destra o potremmo generalizzarlo a tutto l’ambiente politico? Che cosa resta di una politica senza idee?
E’ un atteggiamento generale che va da sinistra a destra, dalla politica all’antipolitica. Certo, in tema di cavalcare gli umori e cogliere le occasioni senza un disegno politico e culturale, la destra ha un’antica dimestichezza, per il suo pragmatismo e la sua pochezza culturale, per la sua furbizia tattica e la sua ottusità strategica. Ma oggi si può davvero dire che tutto il paesaggio politico sia su questa lunghezza d’onda (onde corte, cortissime). È la miseria della politica che legittima la disaffezione come l’antipolitica.
Non ci stiamo forse preparando alle elezioni del quattro marzo con una destra senza cultura e priva di quei valori che da essa germogliano?
La destra esiste più nel paese che nella rappresentazione politica. Esiste laddove si tutela e si promuove il senso dei legami comunitari e tradizionali, l’amor patrio, il valore della famiglia, il sentire comune, civile e religioso, la meritocrazia, il senso del confine, il primato del vicino rispetto al lontano. La politica, quando sente odore di elezione, cerca affannosamente di sintonizzarsi su questo modo di sentire e allora rilancia, a volte con parole, rituali e gesti goffi di mostrarsi come i portatori di quei valori. Tutto sommato, la destra politica o chi ne fa le veci (la Lega salviniana) simula il gergo della tradizione, ma alla fine è sempre meglio del nulla o del tentativo opposto, di rappresentare il gergo della “liberazione” (in tutti i sensi, sessantottini, radical e antifascisti).
Nei suoi libri, nei suoi articoli e nelle sue interviste spesso parla di un canone che si sta imponendo con grande insistenza, il politicamente corretto. In che ambiente culturale sorge e quali sono i suoi effetti?
Penso che l’atto di nascita di quel codice ideologico e di quel canone moralistico sia stato il ’68. Il politicamente corretto sorge quando tramonta la speranza rivoluzionaria del comunismo, l’idea di cambiare il mondo, i rapporti di classe, la società e lo stato. Allora si cerca di cambiare il lessico, di inseguire e proteggere non più il proletariato (salvo i migranti) ma le categorie protette e ritenute svantaggiate. E sorge quel canone di ipocrisie e divieti, di totem e tabù che sconfina nella persecuzione giudiziaria di chi non si conforma. Il p.c. è a mio parere l’erede del Pc nel senso di partito comunista: è il pc dopo il ’68. E non riguarda solo l’Italia ma il mondo intero, affermandosi in modo particolare negli Usa in forma di “bigottismo progressista” (Hughes), nei paesi scandinavi e in tutta Europa. È lo spirito radical che sostituisce l’anticapitalismo con l’antifascismo, la lotta di classe con la lotta dei sessi (e degli omosessi), i proletari con i migranti, lo spirito antiborghese con lo spirito antifamiglia.
Recentemente ha pubblicato tre libri: “Imperdonabili”, “Alla luce del mito” e “Tramonti”: da parte sua sembra ci sia l’individuazione di un problema, quello di una civiltà che si sta definitivamente smarrendo, e di una soluzione segnata da un legame vivo con il passato. È così? Ce ne parli.
La civiltà al tramonto è in effetti lo sfondo dei miei libri, è la convinzione di essere sull’orlo di una fine, mentre non si ravvisano i segni di un inizio. E poi il prevalere dei morti sui nati, dei vecchi sui giovani, sono gli indicatori biologici di quel declino in cui siamo immersi. Il senso della continuità – col passato ma anche con l’avvenire, e più che col passato con l’Origine – è il cuore profondo della tradizione. Ed oggi riconnettersi, riannodare quel filo sommerso è in effetti un grande tema fondativo. Ma in prospettiva, resta l’idea di una nuova nascita, di un Nuovo Inizio. Nutrito dalla convinzione che i miti siano necessari per rianimare la tradizione e propiziare l’Inizio, che i grandi autori inattuali e imperdonabili siano gli anelli di una catena di pensiero che può suggerire un cammino e suscitare una visione del mondo…
Fonte notizia
www.facebook.com EnricoNadaiUfficiale